La poesia è morta? Considerazioni intersezionali sul fenomeno dell'Instapoetry
- Chiara Tommasi
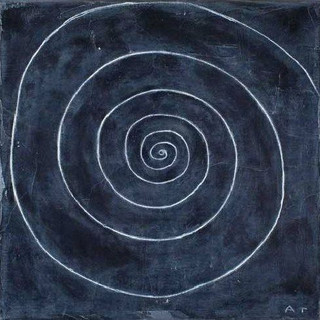
- 21 dic 2024
- Tempo di lettura: 5 min
Aggiornamento: 15 gen
Che la poesia sia tessitura musicale di linguaggio e di senso, è chiaro fin dal suo mito: Orfeo scende negli inferi cantando. Eppure, dare una definizione univoca di questo genere letterario rimane una sfida. Oxford Dictionary prova a descriverlo come “il momento in cui si realizzano individualmente e si rendono intelligibili le possibilità creatrici e suggestive delle intuizioni e della fantasia.” Ma chi stabilisce quali intuizioni possano essere considerate poesia? Quali sono i criteri che definiscono la validità di un’arte, per sua natura, soggettiva?
Il dibattito è oggi, più che mai, attuale. Negli ultimi anni, di fronte alla crisi dell'editoria, la poesia è stata tra le prime forme letterarie a essere sacrificata, considerata ormai uno strumento espressivo poco accessibile e obsoleto, se non addirittura anacronistico. A questa percezione contribuisce forse un sistema scolastico che propone un antiquato studio analitico e costringente della poesia, allontanando i giovani studenti da ogni possibile immedesimazione; il vero nodo, tuttavia, va rintracciato nelle abitudini di consumo della società contemporanea, sempre meno incline alla riflessione profonda che la poesia richiede. In un’epoca dominata dalla distrazione, infatti, dove il pensiero critico cede il passo a una ricezione passiva e disimpegnata, e la formazione di opinioni personali viene sempre più trascurata, non sorprende che le case editrici marginalizzino la poesia e che i poeti contemporanei debbano lottare con le unghie e con i denti per conquistare uno spazio tra gli scaffali delle librerie.
Eppure, proprio mentre la poesia tradizionale sembra arrancare, un nuovo sotto-genere poetico ha riscosso grande fortuna nel mondo del web: l’Instapoetry. Considerata dai puristi come un mero fenomeno mediatico di scarsa qualità, colpevole della morte dell’autentica Ars Poetica, per molti lettori rappresenta invece una vera e propria avanguardia che miscela la spontaneità tipica del blog adolescenziale con una più ricercata aspirazione lirica.
Caratteristiche distintive dell’Instapoetry sono, infatti, l’immediatezza dei contenuti, la semplicità della forma e un’estetica accattivante, fatta di versi sparpagliati nella pagina, non tanto con una precisa intenzione comunicativa, quanto più con l’intento di generare un impatto visivo immediato. Breve, accessibile, istantanea: questa nuova poesia – concepita per una fruizione rapida che non richiede particolare sforzo interpretativo – non ha conquistato soltanto i social media, ma è altresì diventata una risorsa preziosa per l'editoria tradizionale. Gli utenti, infatti, esulano la loro funzione di lettori e acquirenti, diventando i protagonisti di una campagna promozionale completamente gratuita: attraverso la ri-condivisione di versi, frammenti e aforismi sulle varie piattaforme, essi alimentano un ciclo di consumo che spinge le case editrici a una vorace caccia all’instapoet, con l’obiettivo di cavalcare la prosperosa onda di questo nuovo trend letterario.
Questa strategia di marketing risulta particolarmente efficace nel panorama mediatico contemporaneo, insediandosi nel paradosso che lo caratterizza: da un lato, l’insaziabile fame di espressione e visibilità; dall'altro, la sempre più pervasiva cringe culture – che stigmatizza l'espressione creativa fine a se stessa, classificandola come un’imbarazzante perdita di tempo – e la stringente pressione a monetizzare ogni aspetto della propria vita.
L'urgenza espressiva si sacrifica così alla logica del mercato: non si cerca più il linguaggio ideale per comunicare il proprio pensiero, ma il modo più efficace per commercializzarlo. E in un mercato già completamente saturo, la soluzione più semplice risiede nel trasformare le proprie esperienze in contenuti facilmente condivisibili ed esteticamente allettanti – in altre parole, perfettamente instagrammabili.

L’Instapoetry sbarca così nell’editoria tradizionale, riempiendo gli scaffali di raccolte poetiche che, pubblicizzate come manifesti di radicalità ed empowerment femminile, riscuotono grande successo, scalando spesso le classifiche globali. Tuttavia, uno sguardo appena più critico rivela come dietro questa apparente presa di potere si nasconda, in realtà, un femminismo soltanto di facciata.
L’elogio della femminilità, la liberazione sessuale, l’abuso e il trauma razziale sono alcuni dei temi più frequentemente trattati da queste opere. Tuttavia, il tipo di donna che viene a delinearsi tra un verso e l’altro – pur vendendosi come una costruzione emancipata e libera di auto-determinarsi – appare al contrario stereotipata e incapace di sottrarsi alla metaforizzazione della sua persona. La donna si trasforma dunque in una bambola animata da una tempesta imprevedibile, una ‘forza della natura’ che, di fatto, non solo non si affranca dalle logiche del male gaze, ma riproduce anzi una forma di weaponized femininity perfettamente inscritta nelle dinamiche patriarcali, basata su una sensualità tutta tacchi, rossetto rosso e capelli in piega.
Non è un caso che sia proprio questa l’immagine a sopravvivere in un ambiente fino al secolo scorso dominato quasi esclusivamente dagli uomini: essa risponde perfettamente alle esigenze di un mercato letterario alla ricerca di una narrazione del trauma femminile facilmente digeribile e commerciabile. Il risultato è il consolidamento di una scrittura confessionale calibrata per essere sufficientemente audace da risultare riconoscibile e immedesimabile dal pubblico femminile, ma non abbastanza radicale da turbare i più conservatori e minacciare realmente l'ordine patriarcale.
Un caso emblematico è quello della poeta, illustratrice e fotografa indo-canadese Rupi Kaur, che dal 2014 ha rivoluzionato il mercato poetico globale pubblicando la raccolta Milk and Honey, guadagnandosi in questo modo il titolo di caposcuola dell’Instapoetry.

Restituendo con uno stile semplice ed elementare la sua esperienza di donna indiana in Occidente, ed esprimendosi (forse un po’ superficialmente) in merito alla questione di genere e del colore, Kaur ha decodificato la perfetta formula per conquistare il mercato occidentale: offrire una narrazione post-coloniale abbastanza esotica da risultare attraente, ma sufficientemente vaga da non disturbare il pubblico mainstream. E in questo modo ha trionfato: il suo successo è stato tale che nel 2017 le vendite di contenuti poetici sono raddoppiate, popolarizzando in questo modo la poesia.
Inevitabilmente, assieme alla fama, sono piovute sull’autrice moltissime critiche, e non sempre leali. Spesso, infatti, è stato sfiorato il confine dell’opportuno, mascherando attraverso giudizi stilistici un acquazzone di snobismo e misoginia che ha sommerso, con lei, l’intera nicchia di poetesse contemporanee.
Paradossalmente, infatti, la democratizzazione della poesia ha finito per alimentare nuove generalizzazioni e pregiudizi, che mirano a incastrare l'espressività poetica femminile alla superficialità, banalità e inconsistenza di contenuti. È quindi necessario chiarire che liquidare l'intero fenomeno dell’Instapoetry come privo di valore e di merito è non soltanto problematico e sbrigativo, ma anche inesatto: oltre ad aver innegabilmente riavvicinato molti e molte giovani alla poesia, questo sub-genere ha anche contribuito alla creazione di uno spazio che incoraggia, attraverso un tipo di comunicazione del tutto contemporaneo, la discussione di temi e problematiche cruciali e attuali, dando contemporaneamente visibilità a voci che rimarrebbero altrimenti inascoltate.
Rimane, dunque, un lecito quesito da risolvere: il coraggio con cui si elabora poeticamente il trauma è sufficiente a giustificare ogni debolezza stilistica? È il contenuto, indipendentemente dalla forma, in grado di generare poesia?
I fedeli sostenitori degli instapoets sembrano articolare la loro difesa non tanto sulla qualità letteraria delle loro opere, bensì sull'onestà e la vulnerabilità con cui affrontano temi personali e intimi. Appellandosi alla soggettività della poesia, suggeriscono in questo modo che l'autenticità di autori e autrici esenti loro dalle critiche formali.
La vera sfida consiste, dunque, nel trovare un equilibrio: riconoscere il valore di queste voci emergenti – specialmente quando affrontano temi urgenti come trauma razziale e violenza di genere – senza per questo rinunciare a una discussione critica sulla qualità letteraria e stilistica delle loro opere. Solo in questo modo sarà possibile salvaguardare l'arte poetica e preservare l’integrità e la varietà dell’esperienza umana, impedendole di perdere, una volta imprigionata in versi sbrigativi e superficiali, il suo carattere e tutto il suo preziosissimo potere.
c.t.





Argomento spiegato veramente bene, nonostante sia molto complesso!