La madre della danza moderna: Isadora Duncan
- Chiara Tommasi
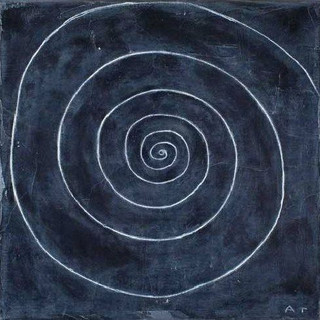
- 8 feb
- Tempo di lettura: 7 min
Aggiornamento: 26 mar
Rubrica: Vita da strega
Tra i vicoli fumosi della Londra del 1900, una giovane donna di appena 23 anni volteggia come visione eterea, sospinta dal vento e dalla pioggia: i piedi nudi, un leggerissimo peplo bianco, una ghirlanda di mirto a coronarle la chioma ribelle. “Vengo dalla luna” risponde all’aristocratico che assiste, rapito, alla scena; una risposta che si conquista un assegno di dieci sterline e la promessa di un pubblico per cui danzare. Quella sera, di fronte all'élite londinese di Grosvenor Square, Angela Isadora Duncan segna un punto di non ritorno nella storia della danza moderna.

Nata nel 1877, Isadora vive la sua prima infanzia in un piccolo appartamento di San Francisco, dove cresce con la madre pianista e i tre fratelli maggiori. Della città ricorda soprattutto l’oceano, le spiagge ventose, il moto circolare delle onde: una natura che scoprirà essere la sua prima e unica musa.
Dopo il prematuro allontanamento del padre, causato da uno scandalo bancario, la famiglia si ritrova a navigare una disastrosa situazione economica, che getta però le fondamenta di una vita vissuta all’insegna di libertà e creatività, svincolata dal rigore dell’educazione tradizionale.
È sulle note del pianoforte materno che Isadora improvvisa i primi passi della sua danza, intuitiva e slacciata dai rigidi canoni del balletto classico, dove i movimenti fluidi e spontanei sostituiscono le fredde geometrie della tecnica tradizionale. A soli sei anni ha già messo a punto il suo stile rivoluzionario, e di lì a poco inizia a condividerlo con le compagne di scuola, esortandole ad abbandonare tutù e mezze punte per abbracciare invece la propria intuizione creativa. La sua visione viene però respinta dalla scuola di danza: allontanata dall’istituzione per la sua mancata disciplina, Isadora decide di fare della strada il suo nuovo palcoscenico.
Munita soltanto del suo esile corpo e di una modesta scenografia – una tenda blu – si sposta di via in via e di teatro in teatro, ma la sua è un’arte troppo moderna e radicale, e nessuno sembra coglierne la potenzialità. La madre, che al contrario sostiene intimamente questa visione, la esorta a tentare fortuna altrove: dopo aver venduto ogni cosa, si mettono in viaggio verso New York.
In questa grande metropoli, Isadora compie la sua prima tournée teatrale, un'esperienza che tuttavia la delude, in cui si vede costretta a contratti che ingabbiano la sua creatività. La attendono anni di miseria e insoddisfazioni lavorative, da cui fugge rifugiandosi nella lettura: divora classici greci, filosofi contemporanei e poeti che incendiano i suoi ideali creativi. Il suo sogno, poco a poco, si fa sempre più chiaro: creare la danza del futuro, basata sulla plasticità greca, sul sentimento, sulla passione dettata dalla natura e dalla musica; una danza che avrebbe dovuto esprimere tutto lo spirito dell’America.
“Mi resi conto che i soli maestri di danza che potessi avere erano il J. J. Rousseau dell'Emile, Walt Whitman e Nietzsche” dichiara; ogni movimento deve essere un inno alla libertà, ogni passo una rottura con le convenzioni accademiche.

Nel 1900, coincidentemente alla scadenza del contratto teatrale, un feroce incendio lascia la famiglia Duncan priva di dimora e di prospettive. Isadora sorride di fronte alle macerie, la tragedia è per lei il simbolo di una liberazione: nuovamente padrona del suo destino, il 7 aprile salpa verso l’Europa a bordo di una nave cargo.
Il successo che riscuote presso i salotti londinesi è immediato e inaspettato: tutti acclamano “la ballerina scalza” e ne tessono profonde lodi. Ma è Parigi a segnare il vero punto di svolta nella sua ascesa artistica. Nella capitale francese, la sua danza seduce l'avanguardia culturale dell'epoca: pittori e scultori la corteggiano, non solo come musa ispiratrice, ma come potenziale compagna di vita. Isadora, però, respinge ogni proposta di matrimonio con la determinazione di chi, sin dall'infanzia, ha scelto la libertà come cardine della propria esistenza.
Tra le giornate al Louvre e le esibizioni nei salotti francesi, affina sempre di più l’utopia di una “umanità danzante”. È con questo ideale nel cuore che nel 1903 accetta una tournée in Russia, pronta a portare la sua rivoluzione verso nuovi orizzonti.
Ad accoglierla a San Pietroburgo, nel gelido pomeriggio invernale, si apre dinnanzi a lei una sterminata processione funeraria. Una miriade di bare scure si stagliano contro il manto candido della neve: sono i corpi degli operai e dei contadini uccisi dalle truppe dello Zar nella domenica di sangue. Questo terribile spettacolo stravolge la sua sensibilità, e risveglia nella giovane un entusiastico spirito rivoluzionario. Fedele alla sua visione di una danza democratica e universale, libera da barriere di classe e genere, decide infatti di esibirsi per il popolo, gratuitamente, un’esperienza che accresce senza dubbio la sua fama, ma che la spinge sull'orlo del dissesto economico.

Si rifugia dunque a Berlino, dove raggiunge l'apice del successo: la folla, in visibilio dopo le sue rappresentazioni, trasporta la sua carrozza in trionfo per le strade della città. In Germania fonda anche la sua prima scuola ufficiale, dove insegna alle sue allieve – le Isadorables – i principi di una danza eterea e spontanea. Le sue coreografie, essenziali ed evocative, prendono vita contro semplici tendaggi blu, una scelta scenografica che diventerà il catalizzatore di un incontro destinato a cambiarle la vita.
Edward Gordon Craig, inizialmente adirato per quella che considera un'appropriazione della sua concezione scenografica, scopre in realtà nell'incontro con la danzatrice non un furto, bensì un'inaspettata convergenza di intenti poetici. "Voi siete l'essere che io sognavo per loro”, afferma Craig guardandola danzare nei suoi fondali blu.
La loro sintonia artistica si trasforma presto in una passione travolgente, coronata dalla nascita della piccola Deirdre. La maternità assorbe completamente Isadora, che vi si dedica con totale dedizione, tanto da allontanarsi temporaneamente dal suo lavoro. Solo l'urgenza economica la riporta sui palcoscenici europei, in un turbinio di esibizioni tra Londra, Berlino e Parigi.
In questo momento di difficoltà entra in scena Paris Eugene Singer, facoltoso industriale che diventa non solo suo mecenate, ma anche un fedele compagno. Il loro amore è cauto e sereno, un porto sicuro dopo le turbolenze e la cieca passionalità che hanno caratterizzato la vita sentimentale di Duncan. La nascita del loro figlio – Patrick Augustus – segna l'inizio di un periodo di serenità e prosperità, che culmina in un lussuoso viaggio in Egitto. Ma con il passare del tempo, la lontananza dalle sue allieve e le sempre più frequenti incomprensioni con Singer spingono Isadora a tornare in Russia, seppur ciò significhi separarsi momentaneamente dai figli.
Durante la permanenza a Mosca, presagi funesti sulla morte di Deirdre e Patrick la ossessionano, portandola a uno stato febbricitante e allucinatorio. Nel 1915, durante uno spettacolo, interrompe il pianista supplicandolo di suonare una marcia funebre. La danza improvvisata su queste note è struggente, quasi estatica: tra un passo e l’altro il corpo sembra farsi trasparente, innalzandosi verso la luce per fuggire la prigione della carne. Il successo è senza precedenti, ma la nostalgia per i figli, le inquietudini e l’insonnia la costringono a interrompere la tournée e fare ritorno in Francia.
I cupi presentimenti, tuttavia, non affievoliscono una volta giunta a Parigi, ed è proprio lì che, poche settimane dopo, il suo incubo diventa realtà. In una giornata piovosa, l’auto che conduce i bambini e la governante al parco, sprofonda nella Senna. È Isadora stessa a riportare i corpicini esanimi a riva, e l’urlo lacerante che esala tenendoli tra le braccia segna la fine definitiva della sua leggerissima e spensierata danza giovanile.
Per metabolizzare il lutto, dopo un soggiorno a Viareggio presso Eleonora Duse, si abbandona a un antico sogno: fondare in Grecia un luogo da consacrare all’arte, degno del genius loci ateniese, un perfetto connubio tra dionisiaco e apollineo. Si trasferisce dunque con la sua famiglia e le sue allieve nei dintorni di Atene, dove avvia la costruzione di un tempio di stampo ellenico, dedicandosi contemporaneamente all’insegnamento della danza alla popolazione locale. Ma questo idillio mediterraneo si rivela effimero: le difficoltà finanziarie e l'improvviso scoppio della Grande Guerra la costringono a cercare rifugio oltre oceano.
Al termine del conflitto mondiale, Isadora fa ritorno in Europa, ormai disillusa sulla possibilità di ritrovare la tanto agognata serenità. Eppure Mosca le riserva un'ultima abbagliante parentesi di felicità: l'incontro con Sergej Esenin.
In una sera d'autunno del 1922, il poeta – di diciotto anni più giovane – la riconosce tra la folla, e tra un bacio e l’altro le sussurra versi composti per lei. Non importa che Isadora conosca appena qualche parola di russo e che Sergej non parli una sola parola d'inglese: il loro incontro si trasforma in una delle più intense e tormentate storie d'amore del secolo. La donna, che vedeva in lui “contemporaneamente un figlio, fratello e amante”, sembra dimenticare le sue tanto perentorie posizioni sul vincolo coniugale e, nella primavera del 1922, i due suggellano il loro amore con una fede dorata.
Tuttavia, l'incomunicabilità linguistica, l'incompatibilità dei caratteri e la spirale autodistruttiva in cui precipita Esenin creano fratture sempre più profonde, e dopo soli quindici mesi, il matrimonio naufraga. Una relazione breve, dunque, ma sufficientemente duratura perché il governo statunitense sollevi la sua disapprovazione, accusando Duncan di bolscevismo e arrivando persino a revocare la sua cittadinanza americana.

Dopo il divorzio le strade dei due si dividono. Esenin non si allontanerà mai più dalla Russia, dove andrà incontro alla morte nel 1925, impiccandosi in un albergo di San Pietroburgo e lasciando come ultima testimonianza una poesia scritta con il suo stesso sangue: “In questa vita, morire non è una novità, ma, di certo, non lo è nemmeno vivere.” Il destino, con la sua implacabile ironia, non sarà più clemente con Isadora.
La danzatrice vede sfiorire la gloria che l'aveva accompagnata per tutta la vita: l'America, che un tempo l'aveva celebrata, ora la scruta con occhio impietoso, accanendosi contro la sua figura appesantita e i capelli tinti. Tornata ancora una volta in Europa, si sposta tra Nizza e Parigi, vinta dall’alcolismo e dai gravi problemi economici. Il sipario, per lei, cala definitivamente nel 1927, con un'uscita di scena non meno scenografica di tutta la sua vita.

A Nizza, il 14 settembre, la sua lunga sciarpa rimane impigliata ai raggi della ruota posteriore della Bugatti su cui si apprestava a lasciare la città, strangolandola. Prima di partire, la sua ultima, definitiva premonizione:
“Adieu, mes amis. Je vais à la gloire!”
c.t.















Articolo molto approfondito e stimolante!!